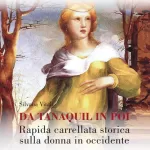Oggi si parla di disturbo di panico con maggiore frequenza rispetto al passato, e questa è una fortuna. Ma perché il dibattito pubblico sia realmente utile è necessario che le informazioni diffuse siano chiare e verificate, che le persone ricevano una diagnosi corretta e che seguano una terapia appropriata. In questo caso, allora sì che il panico smette di essere un mostro che perseguita e impedisce di vivere appieno la vita. Allora sì che le cure funzionano. Allora sì che si può guarire.
Attacchi di panico: scegliere la terapia appropriata
Abbiamo intervistato su questo tema il massimo esperto italiano di panico, Giampaolo Perna, Docente di Psichiatria presso la Humanitas University e Direttore del Mental Health Center Gruppo Humanitas.
Professor Perna, lei è riconosciuto come il massimo esperto italiano (e fra i massimi mondiali) del disturbo di panico, un disturbo che oggi sembra essere più diffuso che in passato: è una percezione corretta o un’esagerazione dei media?
Direi che è più la seconda. Il panico è sempre esistito nella storia dell’uomo, ma oggi ci si nasconde di meno. La vecchia concezione della salute mentale portava, in passato, alla distinzione netta fra “sani” e “matti” e spingeva chi soffriva di panico a nascondersi. Nei racconti di quando era un giovane psichiatra all’interno di un manicomio enorme e affollatissimo, Donald Klein (uno dei massimi studiosi di questo disturbo) osservava che alcuni pazienti sembravano avere meno problemi rispetto alla media. L’unica cosa anomala che facevano era bussare disperatamente al box degli infermieri di tanto in tanto.
Dopo l’approvazione dell’imipramina [farmaco antidepressivo triciclico, ndr], lui fu il primo a somministrarla a questi pazienti: il risultato fu che smisero di battere i pugni contro le finestre. Da qui nasce il concetto di panico come di una patologia della sfera ansiosa curabile con farmaci che sono più tipici della categoria degli antidepressivi che dei sedativi.
Oggi è ragionevole pensare che almeno 150 milioni di persone al mondo e almeno un milione (ma io direi anche 2-3 milioni) di persone in Italia soffrono di questo disturbo. Come vede, si tratta di una patologia molto comune. È importante, però, stare molto attenti a distinguere l’attacco di panico dalla crisi d’ansia. Dobbiamo tenere presente che, quando sentiamo un certo attore o cantante famoso raccontare dei propri attacchi di panico, siamo davanti ad una valutazione più mediatica che clinica. Il primo aspetto importante, quindi, è ottenere una diagnosi corretta.
Il panico si manifesta in modo caratteristico anche con sintomi fisici (dolore al petto, palpitazioni, sudorazione, nausea, vertigini, …) tanto che un episodio può essere a prima vista confuso con un attacco cardiaco: è possibile che la situazione di allarme fisico che la persona vive in maniera così intensa derivi da uno stimolo reale e che non sia quindi semplicemente immaginata?
Questo è l’elemento centrale che distingue la visione del panico attuale da quella del passato, che ancora da molti per la verità non è stata completamente abbandonata. Un tempo si riteneva che le manifestazioni fisiche presenti nel panico fossero semplicemente “falsi allarmi”. In realtà, sappiamo dagli studi scientifici che il corpo di chi ha il panico comunica realmente in maniera anormale, non coerente.
Mettiamoci nei panni di una persona che vive uno stimolo fisico particolare, come può essere il cuore che batte più velocemente del normale. Se il batticuore subentra dopo che ha fatto una corsa, tutto normale: il suo cervello ricollega, sia in maniera consapevole che in maniera automatica, il batticuore allo sforzo fisico compiuto. Ma se il cuore batte forte mentre sta seduto davanti alla televisione, il cervello non trova più una coerenza, una logica in questo tipo di reazione. Osserva che il corpo parla in maniera anormale e vede in questa anomalia un possibile rischio per la vita: quindi, scatena l’allarme che, nelle persone che soffrono di panico, è la crisi.
Questi individui, dunque, hanno realmente un corpo un po’ più fragile. Pur non essendo malato, pur non avendo malattie del cuore o dei polmoni o dell’equilibrio o ancora del sistema gastrointestinale, in qualche maniera questi sistemi sono un po’ più sensibili, un po’ più fragili. A volte, anche piccoli stimoli possono scatenare azioni inappropriate e, quando la mente si accorge di ciò, attiva l’allarme, perché se il corpo non funziona bene il rischio è la morte e questo è un rischio che non possiamo permetterci di correre. Ecco perché questo allarme è molto, molto potente ed ecco perché l’attacco di panico si manifesta con l’intensità che conosciamo.
Oggi il disturbo di panico viene studiato con un approccio nuovo: la cosiddetta “teoria euristica” ha cambiato la maniera con cui viene curato?
Quella che sto attualmente studiando con la mia équipe è una teoria del panico come espressione di un’alterazione del senso di benessere fisico. Cosa vuol dire? Come dicevamo prima, le persone che soffrono di panico hanno un corpo che parla male. È, infatti, evidenziato da tutta una serie di ricerche che questi pazienti hanno anche un sistema dell’equilibrio che non è esattamente uguale a chi non ha il panico, hanno un cuore un po’ più rigido e respirano in maniera un po’ più irregolare. Il corpo non ha nulla di grave, intendiamoci, ma è un po’ più instabile del normale: si adatta con più difficoltà ai cambiamenti interni al corpo e del mondo esterno.
La teoria euristica (il termine euristica si riferisce al fatto che si tratta di una teoria molto pragmatica) ci dice sostanzialmente che i sintomi fisici provati durante gli attacchi di panico e tra un attacco e l’altro non sono delle paure immaginarie, non sono dei condizionamenti psicologici puri, ma sono i segnali di qualcosa di fisico che non funziona bene.
Qual è la conseguenza di questo? Che non basta intervenire dal punto di vista psicologico, ma bisogna far sì che il corpo della persona torni a parlare in maniera equilibrata e coerente. Torniamo all’esempio concreto dell’esercizio fisico. Se corriamo, aumenteranno i nostri livelli di acido lattico, il segno della fatica. In una situazione normale, se sentiamo la fatica e ci fermiamo non abbiamo problemi. Ma se infondiamo dell’acido lattico in persone che soffrono di panico (questa tecnica è stata testata nel corso di alcuni studi) induciamo un vero e proprio attacco: il cervello percepisce picchi di acido lattico senza che ci sia stata una corsa e lo registra come un dato incoerente.
Poiché sono inaspettati e imprevedibili, gli attacchi di panico vengono vissuti come un pericolo incombente che aleggia continuamente sulla vita di chi ne soffre, che tende così ad evitare circostanze pubbliche e di vita sociale. Ciò riduce la qualità di vita, mette a dura prova anche la famiglia e gli amici e insinua un sentimento di rassegnazione nei confronti del disturbo. Ma se il trattamento è appropriato e viene seguito correttamente quali sono le probabilità che abbia successo?
Dal mio punto di vista, dal punto di vista delle esperienze che ho stratificato e degli studi che ho fatto, il 100%. Con un trattamento corretto, la possibilità di avere una restitutio ad integrum, che non significa semplicemente stare meglio ma vuol dire stare totalmente bene, è del 100%. Nella vita reale, in base all’esperienza sul campo, le direi 99%: esiste qualche caso per il quale si fa più fatica a capire perché non risponda alle cure, ma sono davvero molto pochi. Il vero problema è fare bene la diagnosi e impostare un trattamento che sia davvero basato sulle evidenze scientifiche e che sia seguito per il tempo e con il dosaggio adeguati. Capita spesso che siamo prescritte terapie giuste ma in maniera sbagliata e questo è un danno per diverse ragioni.
Anzitutto, perché il successo della cura è messo a rischio. E poi perché l’errore porta la persona a non credere più nell’efficacia delle terapie in generale. È molto difficile spiegare ai pazienti che si trovano in questa condizione che il problema non è il farmaco o la psicoterapia ma la modalità con cui vengono impiegati. È fondamentale precisare che l’obiettivo della cura non è semplicemente bloccare gli attacchi di panico ma quello di restituire un senso di benessere fisico completo. In mancanza di questo senso di benessere completo, la persona continuerà a giocare in difesa evitando e avendo paura di star male pur non avendo più attacchi di panico veri e propri. Solo il recupero del benessere completo, in chi ha sofferto per gli attacchi di panico, gli permetterà di tornare ad aver fiducia nel proprio corpo, ritornando ad affrontare la vita e il mondo con completa libertà e autonomia.
Per rispondere alla sua domanda, quindi, si può tornare a star bene al 100%: di questo sono assolutamente convinto. Tantissimi pazienti hanno avuto la fortuna di ritrovare la libertà assoluta, non di stare meno peggio dovendo comunque combattere sempre con il mostro nascosto, ma di liberarsene.
Professore, in base alla sua esperienza, qual è la percentuale di pazienti che, dopo una diagnosi corretta, seguono effettivamente il trattamento in maniera appropriata?
Dipende da tanti fattori: quello che dice la letteratura scientifica è che i tassi tendono ad essere bassi. Si dice, in medicina, che il 40% dei pazienti non segue quello che suggerisce il medico. In particolare, l’aderenza alle terapie aumenta significativamente se il medico/psicoterapeuta coinvolto le spiega bene, facendo quindi una giusta psicoeducazione.
È chiaro che se prescrivo una terapia farmacologica, poniamo l’esempio, spiegando nel dettaglio gli effetti collaterali, quanto funziona, quali problemi può dare e mi rendo disponibile a intervenire in caso di difficoltà, in questo caso il senso di fiducia del paziente nei miei confronti sarà molto alto. Questo aspetto è molto importante nel panico, perché molti dei farmaci che si usano per curarlo possono peggiorare i sintomi nelle prime 2-3 settimane. È quindi chiaro che, se non avverto il paziente di ciò e non gli offro supporto, la possibilità che abbandoni la cura è concreta.
La fase di spiegazione è centrale: è fondamentale che il paziente si senta davvero capito. Una delle domande che pongo sempre al termine del primo colloquio è questa: Lei pensa che io abbia capito qual è il suo problema? Creare un rapporto di fiducia è l’elemento centrale, che nasce da una buona conoscenza e da una psicoeducazione adeguata.
I sintomi degli attacchi di panico sono molto variabili da soggetto a soggetto: quindi anche il trattamento deve essere personalizzato?
Assolutamente sì. Il trend attuale della Medicina, in generale, è quello della personalizzazione delle cure. Io stesso ho dei ruoli in questo ambito, nel senso che sono il riferimento della Associazione Mondiale della Psichiatria (World Psychiatric Association) nell’ambito della Psichiatria Personalizzata e guido la rivista scientifica Personalized Medicine in Psychiatry.
Perché è importante impostare un trattamento personalizzato? Perché soltanto quando diamo il farmaco giusto al dosaggio giusto per una determinata persona otteniamo un buon risultato, che significa massimizzarne l’efficacia e minimizzarne gli effetti collaterali. Prescrivere un farmaco che ha come potenziale reazione avversa una disfunzione sessuale ad una persona di 95 anni non è come prescriverlo ad una persona di 18. Ma se il paziente è giovane e il panico gli causa malessere profondo, inizialmente lo scopo della terapia è quello di farlo stare meglio e, in un secondo momento, si penserà ad una soluzione ottimale in senso più ampio. Questo fa capire come io debba scegliere la terapia non solo in base al disturbo, ma anche in funzione della persona. Nel trattamento del panico la cura deve anche essere personalizzata sul “tipo” di panico: esistono molte differenti tipologie di panico che rispondono differentemente ai vari tipi di terapie antipanico e solo se viene scelta la terapia corretta si arriva a ritrovare il benessere completo. Ciò va anche a favore dell’aderenza alla cura, un aspetto importante dato che il trattamento del panico deve essere mantenuto per almeno un anno. Il medico deve prevedere l’andamento della cura e gli effetti collaterali che essa potrà provocare, insieme alle esigenze del paziente: solo in questo modo si può mantenere la terapia nel tempo.
In passato sopravviveva un certo pregiudizio nei confronti degli psicofarmaci, che in molti casi di fatto riduceva le possibilità di cura dei disturbi psichiatrici. Quando sono necessari i farmaci per trattare il panico? Sulla base della sua esperienza, i pazienti oggi hanno una consapevolezza migliore sull’importanza della terapia farmacologica?
Il pregiudizio non è rimasto nel passato, ma sopravvive nel presente. Ed è alimentato sia dalla storia degli psicofarmaci che dall’uso scorretto che se ne è fatto, che ha contribuito a creare un’immagine negativa. Un secondo aspetto importante è legato al termine stesso di psicofarmaci, un errore di concetto, perché si tratta di medicinali che agiscono non solo sul cervello ma, anche se in misura minore, su tutto il corpo. Ci tengo a sottolinearlo in questa intervista perché, in particolare nel caso del panico, molti dei farmaci usati non solo modificano i livelli della serotonina e di altri neurotrasmettitori nel cervello, ma intervengono anche nel funzionamento del corpo. Rendono il cuore più flessibile, riducono le irregolarità a livello respiratorio, migliorano l’equilibrio. Consideriamo i farmaci antipanico della categoria antidepressivi [farmaci inibitori della ricaptazione della serotonina, SSRI], che hanno anche un effetto anticoagulante. Se ci pensa bene, come vediamo nella comune terapia dei disturbi cardiovascolari, l’attività anticoagulante ha effetto cardioprotettivo. Sappiamo dagli studi effettuati che il panico attivo è associato ad un rischio di morbilità cardiovascolare maggiore rispetto al normale: bloccando gli attacchi di panico, il farmaco protegge anche il cuore. Parlare di psicofarmaci è proprio un errore: sarebbe molto più corretto parlare di farmacologia in generale e non di psicofarmacologia, termine che rappresenta un elemento di pregiudizio.
Quando sono necessari i farmaci nel trattamento del panico? Se l’obiettivo è quello di portare il paziente a stare perfettamente bene (l’unico obiettivo che ritengo possibile), i farmaci sono molto importanti, in associazione con la psicoterapia cognitivo comportamentale. Il farmaco agisce sul meccanismo scatenante il panico, sul sistema di allarme del pericolo somatico, normalizzando la maniera con cui il corpo reagisce agli stimoli che riceve dall’ambiente. Dall’altra parte, però, soprattutto quando il disturbo dura per anni, si creano abitudini comportamentali e cognitive per cui la persona si comporta e pensa in maniera automatica come se ci fosse sempre il panico dietro. Anche quando il panico non c’è più, rimane il condizionamento e, in questo caso, la psicoterapia fatta per bene che agisca sia a livello comportamentale (tramite esposizione comportamentale) sia a livello cognitivo (modificando gli automatismi di pensiero) permette di arrivare al 100% di ripresa.
Quindi, sì alla terapia farmacologica mirata. Ricordo anche che bisogna avere soprattutto pazienza e aspettare quel mese-mese e mezzo che faccia effetto, senza abbandonarla.
La psicoterapia è importante e deve essere fatta secondo i criteri corretti. Nell’ambito delle diverse tecniche cognitivo comportamentali esistono aspetti di provata efficacia e aspetti la cui efficacia non è dimostrata. Un po’ come per i farmaci, le tecniche devono essere selezionate.
Ma il trattamento del panico non si risolve in questo. Esiste un aspetto legato agli stili di vita: è dimostrato scientificamente che l’attività fisica aerobica è antipanico e che il fumo di sigaretta può peggiorare o indurre gli attacchi di panico. Uno stile di vita corretto e mirato ha efficacia specifica sul disturbo. Praticare esercizio fisico aerobico regolarmente almeno 3 volte alla settimana per 20 minuti e ridurre/smettere il fumo sono già un passo avanti verso il benessere.
In conclusione, guardando al futuro prossimo, accanto a tutti questi interventi si sta sviluppando una riabilitazione di tipo somatico, cioè una serie di interventi sulla variabilità cardiaca, sul sistema respiratorio e tecniche di riabilitazione posturale che potranno integrare le attuali cure nell’ottica di raggiungere quel 100% di benessere di cui parlavamo e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo.
Dott.ssa Monica Torriani farmacista per Redazione VediamociChiara © riproduzione riservata