Virus e batteri che cambiano: come difendersi?
Virus e batteri: dopo anni in cui, grazie ai tanti strumenti che la medicina ha messo a disposizione, le malattie infettive sembravano un ricordo del passato o una problematica dei Paesi meno sviluppati, oggi batteri e virus stanno riconquistando nostro malgrado gli onori della cronaca.
Ma quali sono le infezioni oggi ritenute pericolose, quelle più temute e quali sono le loro cause e i segnali che esprimono e che possiamo sfruttare per intervenire tempestivamente?

il prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell’I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano.
Professor Pregliasco, si sta tornando a parlare di malattie infettive come di un focus di grande interesse per la salute pubblica. Dopo Covid, ora siamo alle prese con la diffusione di microorganismi che fino a pochi anni fa non destavano preoccupazione alle nostre latitudini, come il virus della febbre West Nile. Perché stanno avvenendo questi fenomeni? C’è una correlazione con i cambiamenti climatici?
In effetti la diffusione di alcune patologie che, come anche espresso dai loro nomi esotici (Chikungunya, West Nile, Zika, … ) avevano una specificità di diffusione in alcuni territori, sta cambiando. Gli spostamenti delle persone, sospesi nel periodo Covid, al termine della pandemia sono ripresi e, anzi, oggi sono forse più frequenti di prima.
Sicuramente, anche i cambiamenti climatici stanno giocando un ruolo in questo fenomeno. In particolare, l’innalzamento delle temperature amplia il periodo di massima replicazione delle specie di zanzare coinvolte nella trasmissione di queste infezioni vettoriali, aumentandone il rischio di contagio e diffusione.
I dati che emergono dagli studi nazionali e internazionali (uno su tutti il Rapporto OsMed dell’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA) descrivono un Paese, il nostro, nel quale si usano ancora troppi antibiotici. Quali sono i rischi personali e collettivi di un’assunzione inappropriata di questi farmaci?
Già negli anni Quaranta dello scorso secolo si era osservato che gli antibiotici, a causa di ragioni assolutamente naturali, potevano andare incontro a quello che ora stiamo vedendo come problema più ampio. L’antibiotico resistenza è la capacità naturale di molti batteri, peraltro quelli principalmente coinvolti nelle infezioni che interessano l’uomo, di resistere all’azione degli antibiotici. Questo fenomeno si basa su un meccanismo di selezione naturale. L’uso di questi farmaci in una fase storica nella quale, in effetti, l’incidenza delle infezioni batteriche si è ridotta in modo significativo è diventato eccessivo, inappropriato.
In particolare, ciò si è verificato nell’ambito degli allevamenti, talvolta non tanto per tutelare la salute degli animali ma per massimizzare la resa. Nell’uomo, gli antibiotici vengono spesso impiegati senza che ce ne sia un reale bisogno: mi riferisco, per esempio, alle infezioni respiratorie come influenza e COVID, tutte patologie di origine virale per le quali sappiamo che gli antibiotici non funzionano. Spesso, gli stessi medici sono in un certo senso indotti ad una sovraprescrizione di questi medicinali dalle richieste pressanti dei pazienti, i quali a loro volta, li usano in maniera non sempre corretta. Ad esempio, a volte non rispettano la durata prevista per la terapia, che viene calibrata dal medico in modo da non essere troppo breve, cosa che potrebbe rendere l’azione degli antibiotici inefficace, né troppo lunga, un aspetto che favorirebbe il contatto fra microorganismi e farmaco e quindi contribuirebbe all’antibiotico resistenza.
Dobbiamo anche tuttavia sottolineare il fatto che negli ultimi anni gli investimenti delle aziende farmaceutiche nello sviluppo di nuovi antimicrobici sono stati limitati, almeno rispetto ad altre patologie come i tumori e le patologie cardiovascolari.
Di fatto, oggi ci troviamo ad affrontare con una certa frequenza situazioni di resistenza, ovvero contesti nei quali è complicato trovare un antibiotico che funzioni. A questo proposito, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già da diversi anni ha definito tre livelli di utilizzo di queste sostanze, individuando quelle da impiegare in prima battuta (categoria Access), quelle nei confronti delle quali occorre prestare maggiore attenzione (categoria Watch) e quelle a cui fare ricorso solo in casi specifici, quando a causare l’infezione sono batteri “difficili” come gli enterococchi, lo Stafilococco aureo resistente alla meticillina (MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus) e i batteri resistenti ai carbapenemi (categoria Reserve).
Soprattutto nella stagione fredda, possono preoccupare sintomi quali febbre, tosse e raffreddore che non passano. Molte persone, trovando gli studi dei medici di medicina generale congestionati, prendono un antibiotico magari avanzato da una terapia assunta precedentemente per evitare complicanze e accelerare la guarigione. Nella maggior parte dei casi, si tratta di una decisione presa nella convinzione di fare la cosa giusta, ma di fatto l’antibiotico è spesso non indicato. Quali consigli pratici può dare al nostro pubblico per gestire questi contesti in maniera appropriata?
Partendo dalla premessa che l’antibiotico è un medicinale da prendere solo su prescrizione medica, il primo consiglio è quello di non usare i farmaci residuati da precedenti trattamenti o suggeriti da persone vicine anche con buone intenzioni. Inoltre, è importante seguire le prescrizioni del medico, sia in termini di frequenza di assunzione che di durata del trattamento.
Sappiamo che le infezioni respiratorie invernali nel 99% sono all’esordio virali. Oggi ne vediamo più che in passato, perché oltre all’influenza circola il virus respiratorio sinciziale (RSV) e abbiamo una presenza altalenante del Covid che, pur meno aggressiva rispetto al passato, imperverserà ancora e potrà essere rischiosa per le persone fragili. L’indicazione, quindi, nello specifico è per tutti come primo approccio il ricorso all’automedicazione responsabile, ovvero ai farmaci sintomatici, quelli che attenuano i sintomi senza agire sulla causa alla base.
In questa fase, la raccomandazione è quella di seguire l’andamento della malattia e, se le cose non migliorano, dopo tre o quattro giorni rivolgersi al medico. Recarsi al Pronto soccorso solo se la febbre è molto elevata e non scende con l’uso degli antinfiammatori, se c’è difficoltà respiratoria o aumento della frequenza cardiaca o, nelle persone più anziane, una sintomatologia neurologica di confusione mentale.
A questo proposito, ricordo che ancora oggi e soprattutto in questo periodo per le persone fragili e gli anziani vale ancora la pena di eseguire il test COVID. Per questa categoria di pazienti è infatti disponibile un antivirale specifico da assumere delle sin dalle prime ore dall’esordio. Si tratta di un farmaco che si prende per bocca e che può prescrivere in molte circostanze il medico di famiglia proprio allo scopo di evitare complicanze nelle persone a rischio.
L’estate che sta terminando ha portato alla ribalta delle cronache numerosi casi di infezioni alimentari. Campilobacter, Salmonella, Escherichia coli… C’è un filo rosso che lega questi episodi o si tratta di casi isolati l’uno rispetto all’altro?
In estate ci nutriamo prevalentemente di cibi che non richiedono cottura. Questo ci espone ad un maggior rischio di infezioni alimentari, perché la cottura al cuore degli alimenti uccide i microorganismi presenti. Anche l’aumento che si verifica nella stagione calda del consumo di cibi freschi, per certi versi caratterizzati da valori nutrizionali interessanti grazie al consistente apporto di vitamine e sali minerali, rappresenta un rischio infettivo. Dunque, dobbiamo ricordare che in estate le malattie non vanno in vacanza.
Alcuni dei batteri coinvolti in queste infezioni non modificano le caratteristiche degli alimenti (odore, sapore) e quindi non producono segni di allarme che possono mettere in guardia i consumatori. La raccomandazione è dunque quella di prestare davvero attenzione e, se non si è sicuri della qualità del cibo, mangiarne in piccole quantità e variare la tipologia. In generale, da questo punto di vista, è lo stile alimentare ad essersi modificato.
Nello scenario attuale, gli antibiotici funzionano sempre meno e si fatica a svilupparne di nuovi ed efficaci, virus emergenti hanno più possibilità di diffondersi e gli spostamenti delle persone sono sempre più frequenti. Le nostre abitudini non possono restare immutate: come possiamo meglio adattarci ad una realtà che sta cambiando rapidamente?
Di fatto, considerando che le malattie infettive ci sono e rappresentano un rischio, negli anni passati esse sono state tenute a bada, come prima ricordavamo, con un uso spesso massiccio e ingiustificato di antibiotici. Oggi, a causa degli stili di vita diversi che pongono maggiori rischi dal punto di vista delle infezioni alimentari, dei viaggi e degli interscambi che (finalmente) dopo il periodo di interruzione legato alla pandemia sono ritornati a livelli addirittura superiori a quelli del passato, dobbiamo individuare modalità differenti di gestione. Vi sono diversi livelli di responsabilità: a livello istituzionale è necessario predisporre dispositivi legislativi specifici, ma anche sotto il profilo personale dovrebbe aumentare il livello di attenzione.
Un elemento triste, che probabilmente deriva come effetto collaterale dalle sofferenze emotive e dalle problematiche economiche del Covid, è dato da una certa disaffezione nei confronti delle vaccinazioni. Ritengo che il focus principale di questo fenomeno sia legato alle discussioni sugli obblighi vaccinali e sulla rapidità con cui, fortunatamente, l’industria farmaceutica ha messo a punto vaccini sicuri ed efficaci. Di fatto, però, questa rapidità è stata da alcuni strumentalizzata per insinuare dubbi e incertezze. Vale la pena ricordare che, da un punto di vista generale, le vaccinazioni hanno determinato nei tantissimi anni in cui sono state realizzate una riduzione significativa della quota di infezioni batteriche e virali. Pertanto, io spero che dopo questi momenti critici, ma che possiamo considerare come effetti conseguenti alla pandemia, le vaccinazioni tornino ad essere un presidio cui i cittadini ricorrono con senso di fiducia. Dobbiamo augurarci che questi strascichi non si ripercuotano sulle altre vaccinazioni, come sfortunatamente stiamo vedendo in questo periodo, ad esempio per il morbillo.
Vorrei sottolineare che la vaccinazione rappresenta un importante strumento di protezione anche per il singolo individuo: chi si vaccina protegge la comunità ma anche se stesso. Inoltre, se le persone si ammalano di meno perché fanno prevenzione, si riducono i costi a carico dei servizi sanitari e, di conseguenza, diminuisce anche il peso economico su ogni cittadino.
Dott.ssa Monica Torriani farmacista per Redazione VediamociChiara © riproduzione riservata































































































































































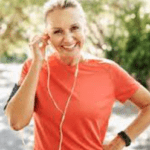



















2 risposte
I vaccini hanno davvero migliorato la nostra aspettativa di vita…ho fatto ben 6 dosi di vaccino anticovid perché rientro tra i “fragili” e nonostante attorno a me ci fossero persone malate – a turno marito, figli, suocera e amici – non l’ho mai preso, o quanto meno se l’ho preso è stato del tutto asintomatico.
Grazie per la tua testimonianza Amalia, la penso come te! Anche io ho un’esperienza simile alla tua. E devo dire che, grazie al vaccino del covid, chi tra i miei familiari lo ha avuto, lo ha avuto in una forma leggerissima o comunque gestibile a casa con qualche giorno di riposo e la tachipirina.